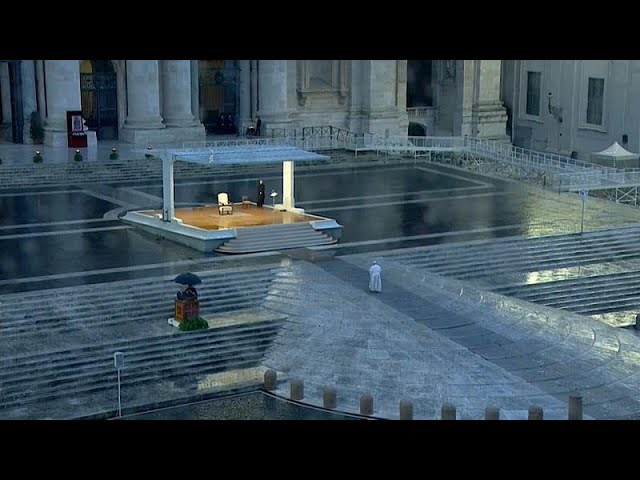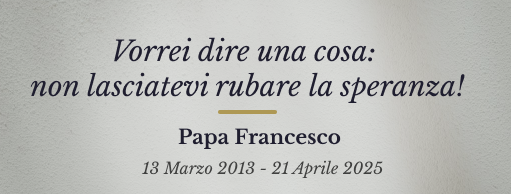(casa Carini anni '80)
(dialetto locale)
Ricordi di Gualtiero Bonfiglioli e Laura Bassi, in parte ravvivati dal libro di Armide Broccoli, "Chiamavano pane il pane"
L'arzdour - L'arzdour l'era al càp famàja ch'al curèva i interès, l'andèva al marchè, al s'mitèva d'acòrd caun chi ètr'arzdòur par i turan dla zèrla, al distribuiva al mansiaun secònd al dèt "vàdar, prevàdar, udìr, capir, intàndar". Al mumàint più bròt dl'an l'era dòp l'incàuntar coun al padroun par i count: l'era narvàus e intratabil parchè al padràun par al cuntrat ed mézadri l'aveva l'esclusiva dla vàndita dal furmaint, dla canva, dl'ù e dal bisti, e quan a jera al rendicòunt al n'era mai vantaz dal contadein.
Come sàgn dal so cmand l'arzdòur al purtèva dau aneli int'agli uràc' e al s'in caveva òna par derla al fiòl ch'l'ereditèva al cmand;: quand l'arzdòur al murèva, al fiol l'erediteva anch la secònda anela.
L'arzdòura - L'arzdòura invezi la controleva al repert dla cusèina, dla cà in generel par vi dla biancari dla cura di amalè caun agli erb medicinel, e anch al repèrt dl'èra. La stèva sàimper 'in cà e al masum l'andèva al marchè a Budri a vàndar agli ov o al galéin e sl'andeva a màsa prèma a la a la dmànga. Tanti volt la famàja patriarchèl l'era fata ed dimòndi fiu caun al sàu spàusi, e spàs a fer da magner aj tuchèva propri al spàusi zàuvni, una stmena proun. Mo l'era sàimper l'arzdàura ch'la deva la raziaun quotidièna par la ragò ed suséza, panzàta, lèrd, ch'la tgnèva int'na sporta.
Al spetaqual piò bel l'era quand la deva da magner al galein e al li ciamèva caun al vers "còchi,, cò-chi"; alàura da tòti al pert agli arivevan ed càursa e al zarchèvan ed parer vi i cuncureint caun di coc' e spintoun. La castreva i galèt par fer i capoun, la controlèva se agli ov agli eran fecondè mitandli càuntr'un raz ed sàul ch'al paseva da una scarvaciè dla fnèstra.
Traduzione
Reggitore (conduttore) Il reggitore era il capo famiglia che curava gli interessi andava al mercato, si metteva d'accordo con gli altri conduttori per i turni della zerla (ossia lo scambio delle opere che pure si praticava fra contadini per molti lavori, come quelli della canapa e della spannocchiatura), distribuiva le mansioni secondo il detto "vedere, prevedere, udire, capire, intendere". Il momento più brutto dell'anno era dopo l'incontro con il padrone per i conti: era nervoso e intrattabile perchè il padrone per il contratto di mezzadria aveva l'esclusiva della vendita del frumento, della canapa, dell'uva e del bestiame, e quando c'era il rendiconto non era mai a vantaggio del contadino. Come segno del suo comando il reggitore portava due anelle nelle orecchie e se ne toglieva una per darla al figlio che ereditava il comando; quando il conduttore moriva, il figlio ereditava anche la seconda anella
Reggitrice (conduttrice) La reggitrice invece controllava il reparto della cucina, della casa in generale per via della biancheria, della cura degli ammalati con le erbe medicinali e anche il reparto dell'aia. Stava sempre in casa e al massimo andava al mercato a Budrio a vendere le uova o le galline, e se andava a messa prima la domenica. Tante volte la famiglia patriarcale era fatta da parecchi figli con le sue spose, e spesso a far da mangiare toccava proprio alle spose giovani, una settimana per una. Ma era sempre la reggitrice che dava la razione quotidiana per il ragù di salsiccia, pancetta, lardo che teneva in un sacchetto.
Lo spettacolo più bello era quando dava da mangiare alle galline e le chiamava con il verso "co-chi co ch"; allora da tutte le parti arrivavano di corsa e cercavano di togliere i concorrenti con degli spintoni. Castrava i galletti per fare i capponi, controllava se le uova erano fecondate mettendole contro un raggio di solo che passava attraverso la finestra.
Al bioic
La stala l'era impurtanta par al lavurir di bû e dal vach int'i camp, par al lat, par l'aldame par al riscaldamaint d'inveren quand la famaja la feva al «tràp», e al biôich l'eveva al càumpit ed bader saul a la stala. Al cureva la pulizi dal bîsti caun la stragia e la bròsca, al li sugheva caun di sách quand al turnevan sudè dai camp, o sl'era piuvò maintr'al lavurevan, agli pasèva la sónza int'la capa par amorbidir i cal dal zò, agli tajèva agli óng' di pi caun al tanaj aposta, d'inveran agli miteva na cuêrta sauvra la schèina s'agli avevan d'ander föra a bovar e al mantneva la pulizi int'la gràpia, intl'aib (abbeveratoio), int'al suichèr e in tot i sit, parché l'igiene l'era in dispensabil par la salut dal bisti. L'era impgnè tót i dè, dal vôlt cumpràisa la dmanga, e da l'èlba al tramàunt.
Il bovaro
La stalla era importante per il lavoro dei buoi e delle vacche nei campi, per il latte, per il concime per il riscaldamento d'inverno quando la famiglia faceva il "trap" e il bovaro aveva il compito di badare solo alla stalla. Curava la pulizia degli animali con la spazzola di ferro e una spazzola con le setole e li asciugava con dei sacchi quando tornavano sudati dai campi, o se era piovuto mentre lavoravano gli passava il grasso nella coppa per ammorbidire i calli del giogo, gli tagliava le unghie dei piedi con le forbici apposta, d'inverno gli metteva una coperta sopra la schiena se dovevano andare fuori a bere e manteneva la pulizia nella mangiatoia, nell'abbeveratoio, nel canaletto e in tutti i posti perchè l'igiene era indispensabile per la salute degli animali. Era impegnato tutti i giorni, delle volte compreso la domenica, dall'alba al tramonto.
Al campagnol
Al campagnol l'era al responsabil ed tot i lavurir di camp, al prém a tachér e l'ultum a smetar, sainza pora dal fràd e dal chèld; i al ciamèvan «quàl ch'al tira al col ai èter», parché l'aveva sàimper la smania ed fer prest, parchè i lavurir i eran dimondi e al tàimp al n'era mai asè. Fra la preparaziàun dal train, la sàmna, al pudèr, l'argôlt, l'aveva da pinsèr anch a difàndar al prodot dal malatî e dai pasarein (e al prepareva i spuràc), mo anch dal rugh, ch'aj dèva la caza insam ai ragazû a forza ed pistút. Al feva anch l'ort, al tgneva indri al smàint par l'an dòp, al cureva i canvi e i fús par l'irrigaziàun e, insàma, al n'aveva mai un'aura dla bôna.
Il campagnolo
Il campagnolo era il responsabile di tutti i lavori dei campi, il primo a iniziare e l'ultimo a smettere, senza paura del freddo e del caldo, lo chiamavano "quello che tira il collo agli altri", perchè aveva sempre la smania di far presto perchè i lavori erano molti e il tempo non era mai abbastanza. Fra la preparazione del terreno, la semina, il potare, il raccolto aveva da pensare anche a difendere i prodotti dalle malattie e dagli uccellini ( preparava i spaventapasseri), ma anche dalle rughe che gli dava la caccia insieme ai bambini a forza di pestarle. Faceva anche l'orto, teneva dietro alle sementi per l'anno dopo, curava i canali e i fossi per l'irrigazione e insomma, non aveva mai un'ora buona.
Al cantinir
La cainteina, interè ed zinquanta zintemiter e esposta ad sáta (a Sud) l'era spàs protéta anch da l'ambra ed quàica pianta, come la vida, cla steva so par al mur esteren. Al cantinir l'era gelàus dla so atrezadura mo anch dal lochèl: an vleva che incióun l'andès in canteina caun dal pan, parchè anch sàul una brisla la pseva arviner na damigiena d'vein baun, opur ch'i purtésan alsi, savȧun, erb aromatich, ch'al psevan arviner al vein caun i udûr. Quand la lóuna l'era bona e an tireva brisa al vàint, al tramudèva o l'imbutiglieva. Mo al period piò impegnativ l'era al tàimp dla vendàmia e poch préma: l'aveva da preparér al sit, i tinaz, i bigónz, busèr al bót o stachèri caun delicatàza al tès (tartaro), controler al calâstar, s'aj manchèva quèch côsa, andèr a la fira di bigónz a San Lázar, indòv l'aveva anch l'ucasiàun ed scambiér un parair o un'esperiáinza caun i colega eccetera. E pò l'arivèva al mumàint ed muster, turcièr, sistemer toti al qualitè ed vein, da cal miòur, destinè a la vandita, al mez vein e al tarzanèl o puntalaun, destinè a la famaja. In particoler al puntèl l'era alzir e bròsch, che anch i ragazû i in psevan bovr a volonté.
Il cantiniere
La cantina interrata di cinquanta centimetri e esposta a Sud era spesso protetta anche dall'ombra di qualche pianta, come la vite, saliva sul muro esterno. Il cantiniere era geloso della sua attrezzatura ma anche del locale: non voleva che nessuno andasse in cantina con il pane, perchè anche solo una briciola poteva rovinare una damigiana di vino buono, oppure che portassero "alsi", sapone, erbe aromatiche, che potevano rovinare il vino con gli odori. Quando la luna era buona e non tirava il vento, travasava o imbottigliava. Ma il periodo più impegnativo era il tempo della vendemmia e poco prima; doveva preparare il posto, i tini, i bigongi, ingrossare le botti o staccare con delicatezza il tartaro , se mancava qualche cosa andare alla fiera dei bigonci a San Lazzaro dove aveva anche l'occasione di scambiare un parere o una esperienza con i collega. poi arrivava il momento di mostare, torchiare sistemare tutte le qualità di vino, dal migliore destinato alla vendita al mezzo vino e al terzo vino, destinato alla famiglia. In particolare il terzo vino era leggero e brusco che anche i ragazzi potevano berne a volontà-
ragazú
Quand in cà a i era di cino an se dscureva d'interes, e spezialmaint quand l'ariveva al padraun, guai i ragazû: o fora o a let. A proposit a m'arcôrd che i ragazû i mandevn a let al 6, e anzi i durmevan int'al stanziôl, una pert dla stala duv a si tgneva la roba pr'al bisti. Tanti volt, invezi ed durmir, i ragazû i stevan a zugher a bréscla, s'i ariuscivan a ruber una quàica candátla. Zerti famaj i fevan durmir i ragazû int'la loza, caun dal fila id let che ed not al «nuni al pasèva da tôt a fèri fer la pipi intl'urineri. A m'arcôrd l'àulum ed casa Marcovigi dóv nuètar ragazû ai zughèvan dàintar. Al tràunc l'era vûd e ai psevan steri fèna in 7.
I ragazzi
quando in casa c'erano dei bambini non si discuteva di interessi e specialmente quanto arrivava il padrone , guai i ragazzi, o fuori o a letto. A proposito mi ricordo che i ragazzi li mandavano a letto alle 6, e anzi dormivano nel stanziol, una parte della stalla dove si teneva la roba per le bestie. Tante volte, invece di dormire, i ragazzi stavano a giocare a briscola, se riuscivano a rubare una qualche candela . Certe famiglie facevano dormire i bambini nella loggia, con una fila di letti che di notte le "nonna passava da tutti a fare fare la pipi nel vasino. Mi ricordo l'olmo di casa Marcovigi dove noi ragazzi ci giocavamo dentro. Il tronco era vuoto e ci potevamo stare fino in 7.
Al ragázi antighi
Par completer la descriziàun dla famaja bisagna dir che spàs a jera anch la zièina o ragâza antiga, cioè zitěla. L'aveva dal mansiaun come na zavata ráta squêsi saimpar ed stopabûs e dal volt la vgneva anch maltraté, spezialmáint dal spausi.
Le ragazze antiche
per completare la descrizione della famiglia bisogna dire che spesso c'era anche la zia o ragazza antica, cioè zitella. Aveva delle mansione come una ciabatta rossa quasi sempre come tappabuchi e delle volte veniva anche maltrattata, specialmente dalle spose.
Al garzaun
Zerti famaj da cuntadein agli avevan al garzàun, ch'l'era qual ch'al fèva i lavurir piò pesant e al vgnéva da famaj ed brazéint. Aj era di ragazû dai 8 ai 11 an ch'i andevan par garzàun saul pr'al magner, sainza pèga, magari par la stasàun estiva. Invezi dai 11-12 an in so spàs i stevan tot l'an: me (parla Gualtiero Bonfiglioli) dal 1938-39 a jó fat al garzàun par 100 scud a l'an, un quintel d'furmáint e un per d'schèrp: d'estè am liveva a mezanot par guarner al bisti e al 2 andeva arer fena al 10.
Il garzone
certe famiglia di contadini avevano il garzone, che era quello che faceva i lavori più pesanti e veniva da famiglia di braccianti. C'erano dei ragazzi dagli 8 agli 11 anni che andavano a fare i garzoni solo per il mangiare, senza paga, magari la stagione estiva. Invece dagli 11-12 anni in su spesso stavano tutto l'anno : io (parla Guartiero Bonfiglioli) dal 1938 -39 ho fatto il garzone per 100 lire all'anno, un quintale di frumento e un paio di scarpe: d'estate mi alzavo a mezzanotte per dar da mangiare alle bestie e alle 2 andavo ad arare fino alle 10.
I brazeint
Què a Granarol I brazéint, come int'agli èter cmóun, i eran quî da pió miseria. Int'al ghetto ed Santa Brigida a in steva dimóndi famaj e par arsparmier la brusàia i s'mitevan d'acord anch a fer al pan a turen. L'evasiàun da tanti misêri e tanti fadigh l'era al tràp, dov a s'zughèva a gufat, a masein o a novzàint (a la màur a s'zughèva piò che èter intl'ustari, par dagli aur, cau dal gran sfilarè d'butèli). I brazèint i fevan na quèch giurneda al tàmp dla canva, di furag', dal mêder o dla vindâmia; opur, quand l'anvèva dimondi, i andevan a Bulagna a scarghèr la naiv dal că, o dai binèri dla ferovi.
I stevan dimondi piz di cuntadein e i sbarchevan al lunèri anch a spighlèr al furmáint, i ga raví, i panucéin. Par scaldères i brusèvan di malghet, di biróc, di sprúch ed canva o dal braguel. I piò furtuné i tulevan da un cuntadein un pez ed tera da lavurer caun un cuntrat a vaus ciamé sal terz» (1 mitevan tota la man d'ôvra e i tgnevan un têrz).
I braccianti
Qui a Granarolo i braccianti, come negli altri comuni, erano quelli da più miseria. Nel ghetto di Santa Brigida ci stavano parecchie famiglie e per risparmiare la legna si mettevano d'accordo anche a fare il pane a turno. L'evasione da tanta misera e tante fatiche era il trap (il trap veniva chiamato , quando dopo cena, si ritrovavano in casa di uno o dell'altro davanti al camino a fare chiacchiere o giocare si diceva va al trap(ndr nonna Giovanna), dove si giocava a gufetto, a massino o a novecento (a la morra si giocava più che altro nelle osterie, per delle ore, con delle gran file di bottiglie). I braccianti facevano qualche giornata al tempo della canapa, dei foraggi, della mietitura della vendemmia; oppure quando nevicava molto andavano a Bologna a scaricare la neve delle case, o dai binari della ferrovia.
Stavano molto peggio dei contadini e sbarcavano il lunario anche a spigolare il frumento, le pannocchine. Per scaldarsi bruciavano i residui del mais, dei carretti, il fusto della canapa o delle cortecce. I più fortunati prendevano da un contadino un pezzo di terra da lavorare con un contratto a voce chiamato "sal terz" (ci mettevano tutta la mano d'opera e tenevano un terzo)